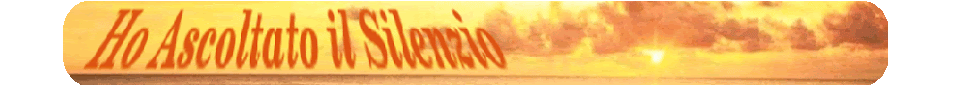EUCARESTIA
"Ecco, l'Eucarestia!
Mamme,
quando avete messo al mondo un figlio
e lo avete stretto forte forte la prima volta fra le braccia,
quali parole gli avete detto?
"ti mangio tutto"!
Perchè grande è stato il vostro desiderio di riprenderlo,
di riformare una sola carne,
in un immedesimarsi sostanziale di un amore consumante.
Questa è l'Eucarestia!
Mamme,
quando avete messo al mondo un figlio
e lo avete stretto forte forte la prima volta fra le braccia,
quali parole gli avete detto?
"ti mangio tutto"!
Perchè grande è stato il vostro desiderio di riprenderlo,
di riformare una sola carne,
in un immedesimarsi sostanziale di un amore consumante.
Questa è l'Eucarestia!
Ciò che noi poveri uomini, Signore, non possiamo fare, tu lo hai fatto.
Noi vorremmo dare il sangue, la vita,
vorremmo morire, consumarci, rinascere, risuscitare, morire ancora...
ma non possiamo farlo;
tu invece, Dio di ogni cosa,
hai creato l'universo perchè questo fosse
e hai fatto sì che potessi impazzire d'amore ogni mattina
quando la tua carne viene in me per divorare la mia,
quando il tuo sangue entra nelle mie vene per bruciare il mio
e per trasformare tutto il mio essere nel tuo.
Ecco la comunione!
Noi vorremmo dare il sangue, la vita,
vorremmo morire, consumarci, rinascere, risuscitare, morire ancora...
ma non possiamo farlo;
tu invece, Dio di ogni cosa,
hai creato l'universo perchè questo fosse
e hai fatto sì che potessi impazzire d'amore ogni mattina
quando la tua carne viene in me per divorare la mia,
quando il tuo sangue entra nelle mie vene per bruciare il mio
e per trasformare tutto il mio essere nel tuo.
Ecco la comunione!
Non voglio sapere Signore, come fai:
che me ne importa?
Non me lo dire...
Se no quasi perderei tutta la poesia e la bellezza dei nostri incontri.
Tu me l'hai già detto "la mia carne è veramente cibo, il mio sangue è veramente bevanda".
A me che me ne importa del resto?
Io che non capisco come funzionano le forze elettro-magnetiche dentro un atomo..
io che non so neanche cosa vuol dire un fotone...
Io che non so come si comporta la luce
e se in essa prevale la natura ondulatoria o corpuscolare...
No, che posso capire di te, diventato umile pane?
che me ne importa?
Non me lo dire...
Se no quasi perderei tutta la poesia e la bellezza dei nostri incontri.
Tu me l'hai già detto "la mia carne è veramente cibo, il mio sangue è veramente bevanda".
A me che me ne importa del resto?
Io che non capisco come funzionano le forze elettro-magnetiche dentro un atomo..
io che non so neanche cosa vuol dire un fotone...
Io che non so come si comporta la luce
e se in essa prevale la natura ondulatoria o corpuscolare...
No, che posso capire di te, diventato umile pane?
vedi, incontrarti per strada può essere bello,
ma come faccio ad abbracciarti?
Mi vedono tutti e poi come faccio a tornare a casa ...
ad andare in ufficio...
e quando ti ho abbracciato?
Beh, un momento ti ho stretto al mio cuore..
poi è finito! Invece così..
nel silenzio della mattina!
Tu ti nascondi, sei là..
tutto vero!
ma come faccio ad abbracciarti?
Mi vedono tutti e poi come faccio a tornare a casa ...
ad andare in ufficio...
e quando ti ho abbracciato?
Beh, un momento ti ho stretto al mio cuore..
poi è finito! Invece così..
nel silenzio della mattina!
Tu ti nascondi, sei là..
tutto vero!
In quell'ostia bianca non c'è nulla che non sia te!
quegli atomi, quelle molecole
che a me sembrano dal di fuori molecole e atomi e cellule di pane, sono Te.
Vedi che sono?
quegli atomi, quelle molecole
che a me sembrano dal di fuori molecole e atomi e cellule di pane, sono Te.
Vedi che sono?
E' inutile che ti nascondi, io lo so.
Ed è soltanto così che puoi entrare della mia bocca,
puoi entrare nel mio cuore,
prendere pezzetto per pezzetto nella mia carne e crogiolarmi nell'amore tuo,
di modo che incantati in questo abbandono neppure gli angeli possono sapere
se sono io o sei tu, e sei soltanto tu!
Ed è soltanto così che puoi entrare della mia bocca,
puoi entrare nel mio cuore,
prendere pezzetto per pezzetto nella mia carne e crogiolarmi nell'amore tuo,
di modo che incantati in questo abbandono neppure gli angeli possono sapere
se sono io o sei tu, e sei soltanto tu!
E' così in adorazione
che io scompaio in te e gli angeli adorano me.
che io scompaio in te e gli angeli adorano me.
Grazie Signore:
diventato Padre Figlio e Spirito Santo!
e quella carne
che è dentro di me
e quel sangue
che è dentro di me
e il sangue formati dal cuore della mamma tua.
Vive dentro di me la carne e il sangue di Maria.
Ho tutto il paradiso!
diventato Padre Figlio e Spirito Santo!
e quella carne
che è dentro di me
e quel sangue
che è dentro di me
e il sangue formati dal cuore della mamma tua.
Vive dentro di me la carne e il sangue di Maria.
Ho tutto il paradiso!
Grazie, Signore Eucarestia!
Enrico Medi